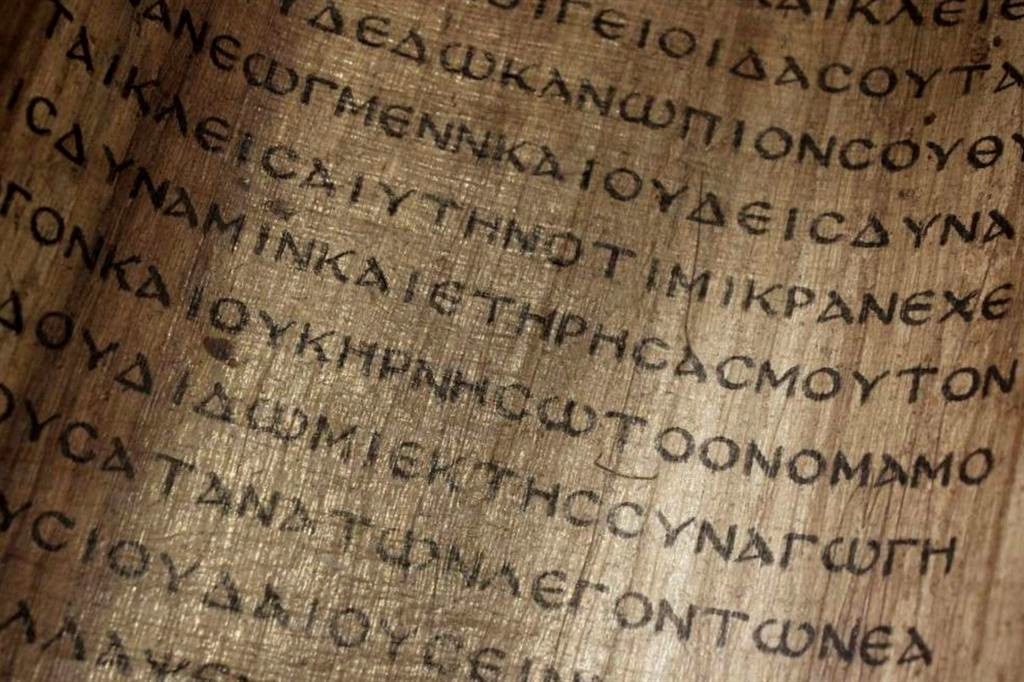A duecento anni esatti dalla composizione di una delle liriche più famose della letteratura italiana, “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, torna utile evidenziare il fondamentale contributo agli studi leopardiani rappresentato da “Leopardi e il «mal di Napoli» (1833-1837). Una «nuova» vita in «esilio acerbissimo»” di Carlo Di Lieto.
L’autore, docente di Letteratura italiana presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha ricostruito in un volume di oltre mille pagine il periodo che va dal 2 ottobre 1833 al 14 giugno 1837, dies emortualis del poeta, in cui il genio di Recanati dimorò nella capitale delle Due Sicilie in “sodalizio” con quell’Antonio Ranieri che diventerà interessato custode delle ultime memorie e degli autografi del suo contubernale.
Tuttavia, si sbaglia chi pensa al lavoro di Carlo Di Lieto come ad opera erudita volta a ricostruire minutamente le tappe del soggiorno partenopeo di Leopardi, tra Palazzo Cammarota ai Quartieri Spagnoli, villa Ferrigni a Torre del Greco alle pendici del Vesuvio, ove trarrà ispirazione per “La Ginestra”, e il “quartierino di sei stanze” in Vico del Pero 2 a Santa Teresa degli Scalzi, zona Capodimonte, ove il poeta incontra quella morte tanto a lungo “corteggiata” nei suoi scritti. La ponderosa monografia si colloca al contrario nel contesto di una collana, “Letteratura & Psicanalisi”, di Genesi Editrice, che dà ragione dell’impostazione della ricerca. È un dato di fatto che a Napoli avviene in Leopardi una metamorfosi che, pur senza indurre radicali revisioni di pensiero, cospira ad un diverso sguardo verso la vita quotidiana e “l’umana gente”. Ci si trova innanzi a quell’atteggiamento che integra la definizione scolastica di “titanismo leopardiano” con tutte le approssimazioni indotte da tale categoria. Complice, in ogni caso, la città di Napoli con quei tratti antropologici unici nel loro genere che ne fanno sì centro “della marioleria universale”, ma con accenti che suonano di ammirazione piuttosto che di biasimo. Di qui la lucida analisi del critico che può affermare con sicurezza che Leopardi “vive in questa città un tempo oggettivo-esterno, a differenza di quanto aveva fatto in passato, vivendo un tempo soggettivo-interiore: un’occasione che a lui non poteva sfuggire dopo aver vissuto la triste esperienza della «prigione» di Recanati”.

Questa sembra la chiave di lettura di tutto il saggio che recupera per Leopardi una categoria, quella del piacere e, per giunta, in accezione epicurea, che appare circondato da perenne disillusione nell’evocazione delle liriche. “Piacer figlio d’affanno” a Napoli sfocia in una dimensione, per l’appunto, “oggettiva-esterna” che “si concretizzerà nel perseguire il bene primario e naturale, quello della gola, fonte di ogni piacere sino a procurargli la morte”. Non è certo l’immagine di un Leopardi-crapulone quella proposta da Di Lieto, ma il suo girovagare tra la Bottega del Caffè a Piazza Carità per godersi i gelati di Vito Pinto, o al Caffè Trinacria, angolo tra Taverna Penta e via Toledo, per sorbetti e cioccolate, consegna un’immagine affatto diversa dell’autore de “L’appressamento della morte”. Napoli da sempre è patria di elezione di Epicuro, almeno sin da quando Virgilio vi trascorreva il suo “ignobile otium”, cantando “Titiro all’ombra del frondoso faggio”.

Per Leopardi “il contatto con la gente partenopea diventa una proiezione di se stesso, nel flusso degli eventi giornalieri; il suo stile di vita si è completamente trasformato, perché il giusto equilibrio tra il corpo e la mente garantirà un po’ di benessere alla sua anima inquieta”. Un giusto equilibrio destinato ad infrangersi con la morte, determinata – pare- da eccesso glicemico. E qui si innesta tutta la querelle della morte, della sepoltura e delle spoglie con una coda polemica che si è protratta sino al 2005 con il diniego da parte del Comune di riesumazione e analisi del DNA dei resti.
Giacomo Leopardi muore, come si legge nell’atto di morte, alle ore 20 del 14 giugno 1837 nell’appartamento di Vico del Pero 2. La causa è da ricercarsi negli strascichi dei festeggiamenti onomastici in onore di Antonio Ranieri, ovvero tre “cartocci” di confetti “cannellini”, due dei quali il poeta avrebbe integralmente consumato. A distanza di oltre due secoli si conservano ancora i residui di questa letale scorpacciata, confetti recuperati da un altro leopardista, Nicola Ruggiero, che li acquisì dall’ultima discendente del portiere all’epoca dello stabile per poi farne dono al museo del confetto di Sulmona. Da questo momento inizia il giallo della sepoltura e delle spoglie.
Leopardi è morto nel contesto dell’ennesima epidemia di colera da cui aveva cercato di trovare scampo mesi addietro rifugiandosi a Torre del Greco, alle falde dello “sterminator Vesevo” scenario della sua ultima, titanica, produzione poetica. Il contesto dell’emergenza colerica impone ordinariamente il seppellimento in fossa comune, destino non dissimile da quello toccato in circostanze simili nel 1791 a Mozart.
Ranieri, all’opposto, accredita la versione di un fortunoso seppellimento presso la chiesa di S. Vitale a Fuorigrotta con la complicità del parroco che avrebbe consentito l’elusione della legge. Di fatto la ricognizione compiuta nel 1900, tra precedenti rimaneggiamenti della tomba e fino alla traslazione definitiva delle spoglie al Parco Virgiliano nel 1939, documentò la manomissione esterna della cassa, ravvisando all’interno resti di “uno scheletro ridotto in pessimo stato” senza cranio e brandelli di tessuto, verosimilmente del già logoro soprabito da cui il poeta non era aduso separarsi in vita. Circostanze queste idonee a suggerire la persuasione che la versione della sepoltura a Fuorigrotta sia stata invenzione posticcia di Antonio Ranieri per accreditarsi come custode della salma e depositario unico della memoria dell’“adorato amico”.
Al di là dell’insoluta querelle, il monumentale saggio di Carlo Di Lieto è un contributo imprescindibile per chi voglia ricostruire l’ambiente allo sfondo dell’ultimo Leopardi. Appare altresì significativo che, a distanza ormai di un lustro dalla sua pubblicazione, sia stato pressoché ignorato dalla critica, specie a Napoli, ove si è data nell’accademia “una congiura del silenzio”. Del resto, Leopardi stesso, che non ha mai amato l’accademia, specie quella napoletana, essendone peraltro ricambiato, polemizzando con i redattori della rivista “Il Progresso”, così scrive ne “I nuovi credenti”: “Ma di tutte maggior, piena d’affanno / A vendetta delle cose belle / Sorge la voce di color che sanno, / E che insegnano altrui dentro ai confini / Che il Liri e il doppio mar battendo vanno.” Anche se con l’Unità d’Italia i confini geografici del Regno delle Due Sicilie tra fiume Liri, Adriatico e Tirreno sono stati abbattuti, mutatis mutandis una certa tendenza autoreferenziale dell’accademia sembra sopravvivere in limiti non più fisici ma ancora una volta corporativi.